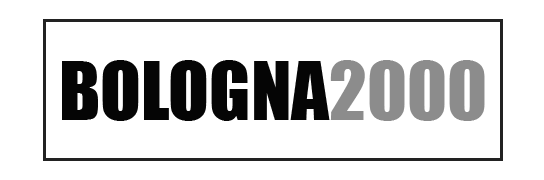A fronte di una produzione nazionale che vanta oltre 5.847 tra cibi tradizionali e denominazioni di origine, l’Italia porta sulle tavole dei consumatori internazionali non più di 200 “veri” prodotti del Made in Italy. La “reputation” del nostro agroalimentare è buona, per la stragrande maggioranza degli stranieri “un must”, ma la cifra mossa dall’export è di quasi 37 miliardi di euro rispetto a un potenziale di almeno 70 miliardi. In sostanza, un paniere molto limitato di prodotti copre oltre il 90% del fatturato complessivo, che per 24 miliardi di euro è generato addirittura da scambi con le sole nazioni di Germania, Francia e Regno Unito. Numeri che fanno riflettere e che sono stati messi al centro del dibattito nell’importante iniziativa che la Cia-Agricoltori Italiani ha promosso oggi a Roma presso l’Associazione Stampa Estera. Un incontro con giornalisti e stakeholder di settore, incentrato sull’analisi dei mercati internazionali per l’agroalimentare italiano e sui progetti che la stessa Cia sta realizzando per promuovere le eccellenze delle aziende agricole nostrane su nuovi mercati stranieri. Un piano di internazionalizzazione portato avanti in partnership con Ice, Gambero Rosso International, Centro Studi Anticontraffazione e Studio Valdani e Vicari.
L’Italia, si è detto in conferenza, produce ad esempio ben 523 vini a denominazione d’origine, ma i consumatori mondiali possono “conoscerne” meno di una dozzina: questo perché gli altri non sono facilmente reperibili sui loro mercati. Quindi, mentre i consumatori internazionali trovano l’Aceto balsamico di Modena, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, i Prosciutti di Parma e San Daniele, il Pecorino romano e il Gorgonzola, ignorano -solo per citarne alcuni- il Caciocavallo Silano, il Fagiolo di Sarconi o il Riso vialone nano del Veronese. Da questo quadro si deduce come il potenziale inespresso dall’agroalimentare italiano sia enorme.
Recenti studi e analisi, su come “vengono percepite” le produzioni italiane all’estero, dicono che ben 4 consumatori stranieri su 10 giudicano la qualità dei nostri cibi superiore rispetto a quella locale, il 43% degli statunitensi chiede più Made in Italy nei supermercati e ben il 74% dichiara di essere disposto a riconoscere un prezzo maggiorato sui prodotti, a patto che siano 100% italiani. La domanda è forte, ancora di più se si considerano quei Paesi praticamente vergini negli scambi con l’Italia o le realtà emergenti come l’Asia.
Eppure i conti sembrano non tornare. A puntare il dito sulla mancanza di una strategia italiana di lungo respiro sulle politiche agroalimentari connesse all’export, è il presidente nazionale della Cia, Dino Scanavino: “Ho il timore che, a forza di parlare solo di ‘km zero’, stiamo relegando le nostre produzioni di eccellenza alla vendita nei mercatini rionali, che complessivamente generano un fatturato inferiore al miliardo e mezzo di euro -ha dichiarato nel corso dell’iniziativa alla Stampa Estera-. Questa strategia ‘limitata’ blocca, invece, un potenziale da almeno 70 miliardi di euro in export”.
Finora, è emerso dalla conferenza della Cia, l’Italia non ha mai messo in campo (o lo ha fatto poco e in maniera disorganica) una strategia funzionale per aggredire i mercati stranieri, organizzando e accompagnando le imprese agroalimentari in questo processo. E anche da qui origina il fenomeno dell’Italian sounding e dei “falsi Made in Italy”, che ha trovato campo libero sui mercati internazionali, venendo a mancare di fatto il presidio dei prodotti “veri”. E tradotto in cifre il business del “tarocco”, va ricordato, muove 60 miliardi di euro ogni anno. Un fatturato totalmente scippato a chi ha costruito nei secoli sul campo, attraverso qualità e sapienza, l’immagine vincente del cibo italiano nel mondo: agricoltori e artigiani.